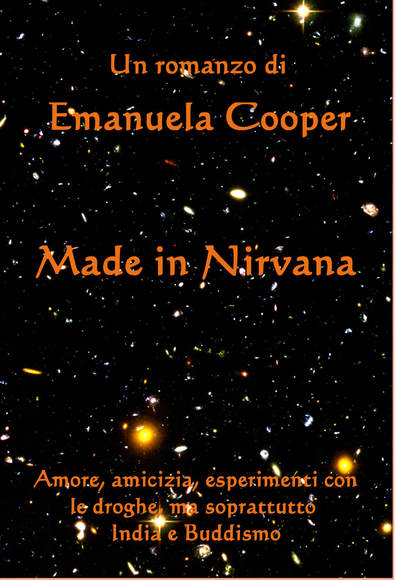MADE IN NIRVANA
Prologo
Maria e ...un dritto un rovescio, un dritto un rovescio.
Prologo
Maria e ...un dritto un rovescio, un dritto un rovescio.
Era una serata umida e fredda di metà novembre e il compleanno di sua madre. Forse la bimba aveva deciso di venire al mondo proprio quel giorno per rallegrarla. Gemma, sua mamma, aveva perso i genitori l’anno prima a soli cinque giorni di distanza l’uno dall’altro. La suocera non le aveva permesso di andare ad assisterli quando erano ammalati; aveva questa famiglia da servire. Gemma si era ammalata di tristezza e aveva perso la voglia di vivere. Se non fosse stato per le due bambine si sarebbe lasciata andare e, mentre era ancora in lutto, scoprì di essere incinta per la terza volta.
Nascere fu un’impresa difficile. La bimba si sentiva spingere lungo la galleria stretta e scura quando la pressione di colpo si arrestò, lasciandola bloccata in una morsa claustrofobica. Seduta ritta sulla sedia, la nonna teneva d’occhio la porta della cucina lavorando disciplinatamente a ferri. Di tanto in tanto lanciava un’occhiata severa alle bambine che fingevano di giocare in un angolino, mentre allungavano le orecchie per ascoltare i rumori che uscivano dalla cucina. Improvvisamente le preoccupanti grida soffocate smisero di colpo e tutto sembrò calmo...troppo calmo. Non giocavano già più quando la zia spalancò bruscamente la porta.
“Chiama l’ostetrica, madre!” gridò tutta agitata, i capelli scuri incollati alla pelle olivastra del viso sudato. “È svenuta. Non spinge più. Il bimbo è bloccato!”
Le bambine potevano vedere la mamma da un ritaglio della porta socchiusa. Distesa sul materasso vicino alla stufa ardente aveva il viso illuminato dalla luce rossa del fuoco, mentre le ombre intorno a lei sfumavano ballando verso il buio sempre più fitto. Sembrava che dormisse, la testa girata di lato, il pancione enorme.
L’espressione della nonna cambiò solo un po’. Serrò le labbra mentre i ferri da maglia si muovevano sempre più veloci: dritto rovescio, dritto rovescio, dritto rovescio. Era un'esperta e non aveva bisogno di guardare i ferri, ma gli occhi erano fissi sulla lana nera arrotolata strettamente attorno all’indice. Dritto rovescio, dritto rovescio, dritto rovescio.
“L’ostetrica costa un sacco di soldi,” disse seccamente. “E quella è al terzo parto!”
Vestita come sempre di nero, strinse le braccia sotto l’enorme petto e lo spinse in su per poi lasciarlo ricadere pesantemente sugli avambracci. Era un segnale chiaro e tondo che su quella decisione non si discuteva. “Datevi una mossa! Tutte e due!” aggiunse, senza distogliere gli occhi dalla lana nera. Dritto rovescio dritto rovescio dritto rovescio. Dritto rovescio dritto rovescio dritto rovescio.
Figuriamoci, l’ostetrica adesso! Come se lei ai suoi tempi avesse potuto chiamare la levatrice! Quantomeno Gemma aveva un marito, il suo unico figlio, mentre lei... Suo marito l’aveva lasciata, e non per un’altra donna, ma per le donne in generale. Che fossero giovani o vecchie, ricche o povere, istruite o ignoranti, pulite o sporche luride, a lui piacevano tutte. Come poteva competere con loro? Era rimasta sola, con due bambini da tirare su e tanta di quella rabbia dentro che le faceva male al cuore. I radi capelli grigi strettamente raccolti in una crocchia le davano un aspetto ordinato, mentre il viso del colore della cera rivelava che non usciva mai di casa. Non è che non le piacessero il sole o l’aria fresca, al contrario, ma era troppo grossa per camminare e, quando ci provava, dopo pochi passi le mancava il fiato. Oltretutto non aveva tempo perché doveva tener d’occhio la giovane nuora, nel caso la storia si ripetesse. Suo figlio assomigliava molto al padre e dipendeva dalla moglie che non si perdesse. Chi altri sennò! Dritto rovescio, dritto rovescio, dritto rovescio. Sapeva che si univano ogni notte, che alla giovane piacesse o no. Ne era sicura perché bastava origliare fuori della porta o guardare dal buco della chiave. Era gelosa della loro intimità, ma era essenziale mantenerlo soddisfatto e dargli da mangiare bene. Gli uomini erano così, bassi, come le bestie!
La zia corse di nuovo in cucina spingendo distrattamente la porta dietro di sé. Non si chiuse completamente, ma lei era troppo preoccupata per accorgersene. “Gemma... Gemma!” gridò. “Svegliati! Torna in qua. Non puoi fermarti adesso o il bambino muore. Devi spingere!” Le diede due schiaffi, uno per guancia, e Gemma aprì gli occhi.
“Sono tanto stanca...” sussurrò, gli occhi offuscati socchiusi per pochi secondi. Abbassò di nuovo le palpebre pesanti mentre girava la testa sul cuscino, lentamente.
“Non puoi fare così!” gridò la zia. “Devi spingere fuori il bambino!” Si passò le dita incerte tra i capelli. Col dorso della mano si asciugò il sudore sulla fronte e sul labbro superiore. “Se non spingi tu, allora spingo io!” dichiarò, disperata ma decisa.
Con le mani tremanti si arrotolò le maniche sopra i gomiti, sollevò la gonna sulle cosce e si mise a cavalcioni appena sopra la pancia gonfia. Si sistemò con le ginocchia ben piantate sul letto, i piedi accanto alla testa della cognata e, senza tante cerimonie, si sedette sul suo stomaco. Cominciò a spingere con tutto il corpo in giù... e in avanti, seguendo l’istinto che la guidava. “Dai Gemma, se vuoi che ti tolga il culo dalla faccia sarà meglio che cominci a spingere anche tu... tanto e forte!” ansimò. Premeva con le mani... in giù e in avanti, proprio sopra il pancione, mentre con le gambe muscolose le stringeva i fianchi. “Avanti, dai che ce la fai!” la incoraggiava, spaventata dalla sua stessa paura. “Spingi, spingi... dai, così. Non fermarti... dai dai... spingi! Facciamo uscire questo bimbo!”
Improvvisamente, come un’onda travolgente, Gemma percepì la corrente di determinazione e un brivido di amore le attraversò il corpo. Voleva che il suo bambino venisse al mondo sano e salvo; sapeva che poteva farlo. Cominciò a spingere cercando di seguire il ritmo della cognata che la cavalcava. Spinse... e spinse... e spinse...
La bimba sentì la pressione che ricominciava a sospingerla ritmicamente. Questa volta la forza era inarrestabile. La lunghissima e claustrofobica attesa nell’oscura galleria soffocante stava per finire e si trovò a precipitare in avanti, cercando disperatamente l’aria. Le mani della zia, calde del sangue della madre, erano pronte a prenderla e con forza la tirarono fuori del tutto.
Sentì un dolore al petto mentre traeva il primo respiro e poi tutto si rovesciò. Si trovò pericolosamente a testa in giù, presa per la caviglia, colpita ripetutamente. Finalmente cominciò a gridare e gridò... e gridò... e gridò, per paura di cadere nel vuoto senza fine, per l’angoscia del brutto viaggio nel canale buio, per il dolore di essere espulsa dal corpo di sua madre.
“È una bambina Gemma!” annunciò la zia enormemente sollevata, guardando la neonata. “Un’altra bambina.”
“Posso prenderla in braccio?” mormorò la madre tendendo le braccia per accoglierla. “Grazie!” disse, spostando lo sguardo pieno di gratitudine dai grandi occhi castani della cognata al piccolo viso pieno di lacrime. Le baciò le guance bagnate. “Ti voglio bene, anche se sei una bambina, mia piccola Maria,” le sussurrò con amore, gli occhi pieni di lacrime.
La nonna spalancò la porta: “Allora... l’hai fatto! Visto che potevi? Voi e l’ostetrica!” Sembrava che volesse sputare quelle parole, lanciando un’occhiata disinteressata al fagottino che urlava, sporco di sangue. “E hai fatto un’altra femmina, vedo... Come se due non bastassero già.”
“Non è colpa mia,” si difese Gemma debolmente, stringendo la bimba al petto.
“Abbiamo una nuova sorellina, mamma?” Le bambine si avvicinarono piene di curiosità. “Possiamo andare a dirlo al papà?”
“Tra poco arriverà a casa,” rispose la nonna con decisione. “Non vale la pena rovinargli la lezione di inglese. Se fosse stato un maschio...”
“Possiamo aspettarlo fuori allora?” supplicarono.
“Sì, fate così,” acconsentì la zia, “mentre noi sistemiamo la cucina. Ma mettetevi il cappotto. Fa molto freddo!”
Corsero fuori inosservate, senza cappotto o berretto e si misero a camminare in fretta verso la scuola serale.
“Ti piace la nuova bimba?” chiese la più giovane.
“No!”
“Perché no?”
“Perché doveva essere un maschio.”
“Ma anche noi siamo femmine!”
“Infatti, questo è il problema. Troppe femmine!”
La piccola cominciò a saltellare.
“Smettila!” comandò la più grande, dandole una sberla sulla testa.
“Perché non posso saltellare?” chiese la bambina, tenendosi a distanza di sicurezza. “Perché non posso?”
“Perché lo dico io!”
Avvistarono il padre in bicicletta che pedalava in fondo alla strada. Gli corsero incontro facendo a gara per arrivare per prima a dargli la notizia.
“Papà, la mamma ha avuto una bambina!” ansimò quella di sei anni, le treccine rigide nell’umidità della sera.
“Sta urlando proprio forte!” gridò quella di quattro, la coda di cavallo che dondolava.
“Una bambina?” disse il padre. “Un’altra femmina?”
Rallentò il pedalare mentre raggiungeva le due figlie.
“Mi fai montare sulla tua bici, papi?”
“Io voglio. Posso montare io con te, papà?”
“L’ho chiesto prima io!”
“Non m’importa. Io sono la più grande!”
Il padre non rispose. Saltellarono accanto alla bicicletta, ma lui andava troppo forte. Allora si misero a correre per stargli al passo, ma anche così rimasero indietro di un bel pezzo. Buttavano fuori il fiato caldo nella scura sera di novembre facendo a gara l’una con l’altra per vedere chi faceva le nuvolette più grandi.
Lo guardarono avvicinarsi alla casa col suo solito stile, sollevando la gamba destra e incrociandola dietro il piede sinistro sul pedale. Coprì gli ultimi pochi metri che mancavano scivolando elegantemente verso casa, come un pattinatore su una pista ghiacciata.
Paul e la partita di calcio
Anche quando era nato lui faceva freddo. La fine dell’inverno era vicina e nella foresta di Sherwood le prime timide gemme cominciavano già a sbocciare. Sua madre stava preparando l’impasto per una torta di more quando iniziarono le prime contrazioni.
“Credo che ci siamo amore,” disse al marito tenendo il pancione con le due mani. “Sta cominciando... ne sono quasi certa.”
“Ma è sabato Jane!” esclamò Bill con sgomento. “La partita di calcio comincia tra meno di... cosa... due ore?” Suo padre guardò l’orologio da polso con costernazione. “Non ho mai perso una partita! Sei sicura che abbia proprio cominciato? Non può aspettare fino a stasera?”
“Potrebbe essere un falso allarme, caro! Successe lo stesso con la nostra Catherine,” concesse la madre, massaggiandosi la parte bassa della pancia. “Perché non chiami l’ostetrica? Dopo puoi andare alla partita. Noi saremo tranquille e sono certa che tornerai in tempo.”
E così suo padre partì con la lucida automobile nera e tornò assieme all’ostetrica. Era una donna tedesca che viveva nella zona di Sherwood da molti anni; ne aveva perso il conto, ma aveva mantenuto un forte accento.
“Portami di sopra la valigia!” ordinò a Bill, “e vediamo a che punto siamo.”
Quando vide Jane tutta indaffarata a mettere in ordine la camera perse quel poco di pazienza che aveva.
“Non sei ancora pronta, donna! Perché mi avete chiamato così presssto?” Senza aspettare la risposta comandò: “Riporta giù la valigia! Mi dovrai riaccompagnare a casa e dovrò tornare più tardi.” Però per scrupolo, mentre Bill scendeva ubbidientemente le scale con la valigia, diede un’occhiata ‘all’uscita’ di Jane. Senza pronunciar parola corse a spalancare la finestra, si sporse di fuori e sbracciandosi gridò a Bill che era già nel cortile: “Torna su! Riportami la valigia. Non è troppo presssto. Sta venendo adesso!”
E così il bambino nacque in fretta e in un modo conveniente per tutti; talmente in fretta che il suo bel papà arrivò alla partita giusto in tempo per vederla cominciare.
Jane teneva il fagottino in braccio quando Catherine apparve sulla soglia. I grandi occhi verdi spalancati, pieni di muta preoccupazione, fissava sua mamma sul letto con un altro bambino.
“Vieni a vedere il tuo fratellino, Catherine.” Jane le porse la mano, ma lei non si muoveva, continuando a fissarli in silenzio.
“Vai a vedere il tuo nuovo fratello!” la incoraggiò l’ostetrica. Visto che la bambina non si decideva, la prese per mano e la portò dalla madre.
“Puoi toccarlo se vuoi,” disse Jane guardandola con amore.
Catherine non riusciva a staccare gli occhi dalle minute dita rosse del bambino. Le toccò con l’indice e sussultò dalla sorpresa quando il bimbo glielo strinse nella piccolissima mano. Guardò la madre, interrogandola con gli occhi sgranati. “Mi ha preso il dito e lo sta stringendo!” esclamò, stupefatta e divertita.
“Perché ti vuole già bene,” disse Jane accarezzandole i capelli. “Vieni a sederti sul letto.”
“Non è igggienico!” rimproverò l’ostetrica, che si chiamava Frida.
“Non preoccuparti Frida, staremo attente. Sei stata bravissima con il parto, grazie!”
Frida corrugò le sopracciglia, ma sapeva che il suo lavoro era finito e che era meglio tacere.
“Che nome gli diamo?” Jane domandò alla figliola, ma lei fissava il neonato, curiosa e confusa, e non rispondeva. “Lo chiamiamo Ernesto?”
La bambina scosse la testa per dire di no.
“Non ti piace il nome Ernesto?” Catherine scosse di nuovo la testa.
“E Paul ti piace? Lo chiamiamo Paul?” La bimba guardò il fratellino a lungo attentamente... e poi annuì.
“Posso dargli un bacio?” chiese finalmente.
“Ma certo! È tuo fratello e quando sarà grande ti proteggerà.”
Si appoggiò alla madre e baciò delicatamente il neonato su una guancia. Il bimbo aprì la piccola bocca sdentata e sbadigliò forte. Madre e figlia risero insieme, emozionate.
“È buffo!” disse sorridendo, sistemandosi più comodamente sul letto vicino alla mamma e offrendo il suo dito alla piccola mano del fratellino. Sorrise felice quando lui glielo prese e lo strinse forte.
Alcuni anni dopo: Maria
Giocava da sola con le bambole mentre le sorelle erano a scuola; la sua preferita era nera con i capelli ricci. Mentre sua madre faceva i lavori di casa lei le vestiva e le svestiva, cambiandole cento volte al giorno. Curiosa di sapere com’erano fatte, ne tirava le gambe e le braccia cercando di guardarci dentro. Era una tentazione irresistibile nonostante ormai sapesse che le bambole erano vuote. A volte l’elastico che le teneva unite si rompeva e le braccia o le gambe si staccavano, sconfitte. Finalmente poteva mettere il dito dentro quei buchi e accarezzare la plastica liscia.
“Vedrai come si arrabbiano le tue sorelle quando tornano da scuola e trovano le bambole rotte!” la rimproverava Gemma.
Con un pezzo di elastico nuovo riattaccava gli arti al corpo, ed era anche brava a farlo perché era difficilissimo, ma le braccia e le gambe non erano più belle unite come prima. E così tutte le bambole della casa avevano le membra un po’ lasche che dondolavano a penzoloni; non stavano più sedute bene e cadevano in avanti in segno di protesta. Le sorelle si arrabbiavano e quando la madre non era presente le davano qualche bella sberla per vendicarsi. Ma la curiosità vinceva sempre e il giorno dopo Maria tirava l’elastico di nuovo.
La nonna stava tutto il giorno in cucina seduta sulla sua sedia, lavorando a maglia in silenzio. Dritto rovescio, dritto rovescio, dritto rovescio. Da lì controllava tutto, ma soprattutto che la madre non uscisse, a parte quando andava a comprare il pane fresco. La sgridava se spostava la tenda della finestra per guardare fuori. Cosa c’era da guardare? Uomini?
“Cosa stai facendo nonna? È per me?” chiedeva Maria. Le piaceva sua nonna con la sua stazza grossa e confortante; si sedeva spesso sulla sedia vicina a guardarla lavorare a maglia.
“No, non è per te. Questo golf è per tua sorella più grande.”
“E quando l’hai finito ne fai uno per me?”
“Devi aspettare. Prima devo farne uno per l’altra tua sorella.”
“Quanto ci metti?”
“Due settimane, tre se non sto bene. Devi aspettare.”
“Me lo fai rosa?”
“Vedremo!”
E lei aspettava. Le ricordavano sempre che era la terza femmina per cui sapeva di non essere importante, anzi... era l’ultima ruota del carro! Le tre settimane sarebbero passate e la nonna avrebbe fatto un golf per lei. Maria aveva fiducia e aspettava.
La madre faceva tutti i loro vestiti. Stendeva bene la stoffa sulla tavola della cucina, faceva i segni con il gesso bianco da sarto, un gesso liscio che non sporcava le mani, tagliava la stoffa con delle forbici grandi e poi univa le parti con gli spilli.
“Mi aiuti Maria?” chiedeva alla bambina seduta dall’altra parte della tavola. “Se mi infili gli aghi lavoro molto più in fretta.”
Lei era bravissima a infilare gli aghi, più svelta di quanto Gemma fosse ad imbastire. Si leccava il dito, faceva il nodo e poi lisciava il filo sulla formica gialla della tavola.
Quando Maria aveva quattro anni Gemma rimase incinta di nuovo. In primavera aveva già il pancione e le serate erano tiepide. Dopo cena tutta la famiglia si sedeva nel giardino che dava sulla strada a bere birra, perché faceva venire il latte. Era vero che loro non avrebbero allattato, ma la birra la bevevano tutti, bambini compresi. Maria ne odiava il gusto amaro, ma siccome per una volta tanto la trattavano alla pari, la beveva anche lei. E poi ridevano e saltavano sui letti; soprattutto la sera in cui Gemma entrò in travaglio. Come se sapesse che questa volta sarebbe arrivato il maschio, il padre l’aveva portata in clinica. Nel giro di dieci minuti il fratellino era già nato, anzi, per poco non finiva giù per il water quando Gemma andò a fare pipì. Per fortuna riuscì a tener duro e ad arrivare fino al primo letto. Sarebbe stato un inizio poco dignitoso per l’erede del nome Dal Fiore! In ogni caso, in cinque minuti era venuto al mondo e la mattina dopo erano già di ritorno a casa.
Un giorno venne un’ambulanza e portò via la nonna. Maria stava andando a trovarla in ospedale con sua zia quando incrociarono il padre che tornava in bicicletta. Si fermò, un piede per terra e uno sul pedale. Guardando sua sorella scosse il capo. “Il cuore... ” disse.
Lei e la zia tornarono a casa. Le mancava la presenza della nonna che lavorava a maglia seduta su quella sedia, ma di lei non parlarono quasi più.
Un mese dopo il padre fece andare tutti giù in cortile e con orgoglio mostrò una grande macchina rossa con il tetto nero, una FIAT di seconda mano che era come nuova. Aveva preso la patente di nascosto, ma spesso si chiedevano se davvero gliel’avevano data perché a loro non sembrava che guidasse molto bene. Era nervoso e sorpassava le altre automobili per dimostrare la sua superiorità a tutti gli altri conducenti. Di fianco a lui, la madre era sempre piena di angoscia. Si metteva la mano sulla bocca e diceva: “Va’ piano, Piero. Non sorpassare, sta arrivando un camion!” oppure: “La curva è stretta. Perché non rallenti un poco?”
Ma il padre si innervosiva ancora di più e quando si degnava di risponderle diceva: “Se non ti va bene Gemma, puoi scendere e andare a piedi!”
Seduta dietro con le sorelle e il fratello, le veniva sempre da ridere quando sentiva quella frase. Anzi, a volte la dicevano i figli stessi ridendo a crepapelle: “Se non ti va bene Gemma, scendi e vai a piedi!”
La madre teneva gli occhi chiusi dal terrore. Una volta giunti a destinazione il padre osservava: “Hai fatto un bel pisolo, eh Gemma! Siamo già arrivati e non te ne sei neanche accorta!”
Alcuni anni dopo: Paul
Più cresceva e più somigliava a sua sorella, con i riccioli biondi e i grandi occhi verdi. Giocavano insieme nel grande giardino dove sua madre coltivava fiori bellissimi di tutte le misure, forme e colori. C’erano fiori in primavera, in estate e perfino in autunno. Gli piaceva cercare ‘creature’ nella terra, ma Catherine scappava gridando quando tentava di mostrarle i vermi che aveva trovato. Per fortuna che spesso venivano i cugini, due femmine e un maschio dell’età di Paul. Scavavano insieme per trovare vermi e insetti di ogni tipo.
Jane coltivava anche verdure in giardino. Cuoceva il pane e i dolci al forno sprigionando un profumo meraviglioso e faceva anche il vino. In autunno mandava i bambini a raccogliere more, consegnando loro un grande secchio di ferro. Tornavano a casa solo quando era completamente pieno e, da quanto pesante era, dovevano portarlo in due. Jane ne era sempre contentissima; diceva loro che erano stati bravi e dava a ciascuno una fetta di dolce e un bicchiere di latte, già pronti sulla tavola col piattino e il tovagliolo. Poi con quelle more faceva i dolci e il vino.
Suo padre era quasi sempre a letto nella camera di sopra che dava sul giardino. Paul gli portava il giornale e il viso di Bill si illuminava in un gran sorriso. Prendeva il giornale con le sue mani magre, eleganti. Nonostante il pallore e la malattia era sempre molto bello, aveva gli occhi buoni.
“Siediti qui con me che ti leggo le ultime notizie,” diceva facendogli posto vicino a lui. “A meno che tu non preferisca che ti racconti una storia!”
“Mi racconti quella del piccolo Buddha?” chiedeva il piccolo, speranzoso.
“Di nuovo? Ma te l’ho già raccontata mille volte. Non sei stanco di sentirla?”
Ma Paul non ne era mai stanco e inoltre suo padre aggiungeva sempre dei particolari nuovi. Si sedeva a gambe incrociate sul letto vicino a Bill, pronto ad ascoltarlo.
“Ti racconto di quando si trovò faccia a faccia con una tigre. Ti piace quella, no?”
Lui adorava quella storia e annuiva con entusiasmo.
Ancora una volta Bill cominciò: “Un giorno Siddharta, così si chiamava il Buddha, andò a caccia della tigre con suo padre, il re Suddhoddana. Era la prima volta perché, essendo una caccia molto pericolosa, i bambini non potevano parteciparvi. Ma siccome Siddharta aveva appena compiuto undici anni, dopo l'enorme festa in suo onore, con tavole imbandite di dolci e frutta, suo padre decise che era ormai abbastanza grande per portarlo con sé insieme agli altri uomini.”
Paul ascoltava attento e chiese: “Non aveva paura?”
“Chi, Siddharta?” chiese Bill guardando il figliolo. Il bambino assentì. “Oh no! Come tanta gente buona aveva molto coraggio! Andiamo avanti?”
Paul annuì forte, sorridendo felice.
“Allora, erano in groppa all’elefante del re, con Siddharta accomodato sul collo grosso e morbido e il re seduto dietro di lui. Senza rendersene conto si trovarono separati dal resto del gruppo quando, all’improvviso, l’elefante si fermò. Aveva sentito un rumore preoccupante proveniente dal bosco di bambù e d’istinto capì che c’era un pericolo. Si abbassò sulle zampe anteriori, preparandosi ad attaccare con le zanne qualsiasi animale lo avesse minacciato!”
Paul sollevò il viso verso suo padre guardandolo ad occhi spalancati, ricordandosi quello che stava per succedere. Bill gli fece l’occhiolino, lo circondò col braccio e continuò: “Siccome Siddharta e suo padre riuscivano a tenersi a malapena in equilibrio sul collo dell’elefante, quando questo fece un movimento brusco si trovarono scaraventati al suolo. Improvvisamente, un’enorme tigre apparve dal bosco di bambù. Il re mise la mano sulla spalla del figlio, ma Siddharta sentì che stava tremando. Senza pensarci due volte, si mise davanti al padre per schermarlo.”
La storia non perdeva mai il suo fascino e Paul tratteneva il fiato. Bill gli diede un colpetto sul ginocchio e continuò: “Soltanto il re Suddhoddana aveva la spada perché al ragazzo, essendo troppo giovane, non era permesso portare un’arma. Nonostante ciò Siddharta non aveva timore. Era faccia a faccia con la tigre e questa aveva il pelo folto e lucido... Era stupenda! La guardò negli occhi: erano gialli, grandi... e pieni di paura. La tigre lo fissava, immobile. Per un lungo istante si studiarono intensamente. ‘Non avere paura, non voglio farti del male,’ voleva dirle, ma siccome le parole non avrebbero funzionato, glielo disse con gli occhi e con tutto se stesso. Era sicuro che lei lo capiva. Lentamente la preoccupazione svanì e si trasformò in curiosità e negli occhi della tigre Siddharta vide una specie di interesse, forse addirittura complicità.”
Paul era tutto teso ad ascoltare la storia e suo padre continuò lentamente: “Allora, volendo rassicurarla, strizzò gli occhi per comunicarle che la rispettava e la capiva. In risposta, la tigre abbassò una palpebra, appena appena. Erano diventati amici e riuscivano a comunicare. Nella giungla c’era un silenzio di tomba, come se tutti gli animali stessero trattenendo il respiro. Siddharta fece un passo verso la tigre; lei non si mosse. Lentamente, le porse la mano a palma in su, per dirle che poteva rilassarsi. La tigre abbassò leggermente la testa, con un grugnito si girò e si allontanò ancheggiando, scomparendo di nuovo dentro la foresta di bambù.”
Paul tirò un gran sospiro di sollievo. Suo padre concluse la storia: “Il re era molto orgoglioso di suo figlio. ‘Hai battuto la tigre,’ gli disse. Ma Siddharta le aveva solo parlato col pensiero e aveva sentito la sua paura. Da parte sua, la tigre aveva percepito la sua bontà, questa cosa tanto speciale in quel ragazzo, e aveva avuto fiducia in lui.”
Paul sorrise con un’emozione dentro che lo faceva tremare, come se avesse sentito la storia per la prima volta: “Siddharta era più coraggioso e più forte del re, vero papà?”
“Sì, molto. Era forte dentro di sé. Aveva molta compassione e questa era la sua forza.”
Paul si rannicchiò il più vicino possibile a suo padre che se lo strinse forte al fianco. Alzò il viso a guardarlo e Bill gli baciò i capelli biondi. Rimasero così, senza parlare, nel letto caldo... per un bel po’.
Quando suo padre andò in ospedale Jane andava a trovarlo ogni giorno, mentre loro passavano il pomeriggio a casa dei cugini. Un giorno Jane tornò a casa della zia con gli occhi rossi e gonfi. Continuava a soffiarsi il naso dentro un fazzoletto da uomo, di quelli grandi e bianchi con il bordino blu che aveva Bill. Quando arrivarono a casa preparò tre tazze di latte caldo e si sedettero intorno alla tavola della cucina a sorseggiarlo in silenzio.
“Il papà non c’è più,” disse ai bambini. “Ma io sono qui e non vi lascerò mai, per cui non dovete avere paura.”
“Dove è andato il papà?” chiese Catherine, sentendo il panico che l’assaliva e le stringeva il cuore.
“È andato dove non si soffre più,” rispose Jane guardando i figli dall’uno all’altro. “Ma vi vorrà sempre bene. Non dovrete mai dimenticarlo!”
“È andato in Nirvana?” chiese Paul.
La madre lo guardò sorpresa e sorrise dolcemente. “Non è un posto tesoro, è uno stato di pace e tranquillità, ma... sì, adesso il babbo è in Nirvana,” confermò accarezzandogli la testa.
“Il papà ha detto che è uno stato!” replicò lui fiducioso.
“Sì, caro!” rispose la madre con un sorriso triste.
Paul sapeva molte cose sul Nirvana. Bill gli aveva detto che era uno stato in cui non si soffriva, anzi si stava proprio bene! Come diceva anche la mamma, c’era pace e tranquillità e nessun timore. Probabilmente era uno stato dove le tigri non avevano paura della gente e i bambini potevano giocarci insieme, magari anche cavalcarle. E forse, in Nirvana, i bambini facevano dei bei pisolini al calduccio in letti comodi, con il loro papà. E da lì i papà non dovevano andarsene mai.
Cominciarono ad andare dai cugini ogni pomeriggio mentre Jane era al lavoro. La zia ebbe un’altra bambina e lasciava che Paul la tenesse in braccio. Aveva dei grandi occhi azzurri e gli sorrideva e questo lo rendeva felice. Ogni sera la madre veniva a prenderli e tornavano a casa. Aveva comprato dei pulcini che poco a poco diventarono galline. Ogni mattina Paul andava in cerca delle uova; a volte le trovava che erano ancora calde e, anche se erano un po’ sporche, le portava a casa avvolte nel maglione. Jane aveva comprato anche dei conigli che tenevano in una cassetta con la retina davanti. I bambini strappavano manciate di erba e le porgevano agli animaletti attraverso la retina. I conigli erano simpaticissimi, prendevano l’erba con le zampine anteriori e la masticavano in fretta con grande entusiasmo, facendoli ridere di soddisfazione. Dopo un po’, siccome nessuno poteva o voleva ucciderli per mangiarli, li lasciarono liberi nel giardino a saltellare e a moltiplicarsi felicemente. Ma un giorno mangiarono tutti i fiori e Jane li dette via.
Nascere fu un’impresa difficile. La bimba si sentiva spingere lungo la galleria stretta e scura quando la pressione di colpo si arrestò, lasciandola bloccata in una morsa claustrofobica. Seduta ritta sulla sedia, la nonna teneva d’occhio la porta della cucina lavorando disciplinatamente a ferri. Di tanto in tanto lanciava un’occhiata severa alle bambine che fingevano di giocare in un angolino, mentre allungavano le orecchie per ascoltare i rumori che uscivano dalla cucina. Improvvisamente le preoccupanti grida soffocate smisero di colpo e tutto sembrò calmo...troppo calmo. Non giocavano già più quando la zia spalancò bruscamente la porta.
“Chiama l’ostetrica, madre!” gridò tutta agitata, i capelli scuri incollati alla pelle olivastra del viso sudato. “È svenuta. Non spinge più. Il bimbo è bloccato!”
Le bambine potevano vedere la mamma da un ritaglio della porta socchiusa. Distesa sul materasso vicino alla stufa ardente aveva il viso illuminato dalla luce rossa del fuoco, mentre le ombre intorno a lei sfumavano ballando verso il buio sempre più fitto. Sembrava che dormisse, la testa girata di lato, il pancione enorme.
L’espressione della nonna cambiò solo un po’. Serrò le labbra mentre i ferri da maglia si muovevano sempre più veloci: dritto rovescio, dritto rovescio, dritto rovescio. Era un'esperta e non aveva bisogno di guardare i ferri, ma gli occhi erano fissi sulla lana nera arrotolata strettamente attorno all’indice. Dritto rovescio, dritto rovescio, dritto rovescio.
“L’ostetrica costa un sacco di soldi,” disse seccamente. “E quella è al terzo parto!”
Vestita come sempre di nero, strinse le braccia sotto l’enorme petto e lo spinse in su per poi lasciarlo ricadere pesantemente sugli avambracci. Era un segnale chiaro e tondo che su quella decisione non si discuteva. “Datevi una mossa! Tutte e due!” aggiunse, senza distogliere gli occhi dalla lana nera. Dritto rovescio dritto rovescio dritto rovescio. Dritto rovescio dritto rovescio dritto rovescio.
Figuriamoci, l’ostetrica adesso! Come se lei ai suoi tempi avesse potuto chiamare la levatrice! Quantomeno Gemma aveva un marito, il suo unico figlio, mentre lei... Suo marito l’aveva lasciata, e non per un’altra donna, ma per le donne in generale. Che fossero giovani o vecchie, ricche o povere, istruite o ignoranti, pulite o sporche luride, a lui piacevano tutte. Come poteva competere con loro? Era rimasta sola, con due bambini da tirare su e tanta di quella rabbia dentro che le faceva male al cuore. I radi capelli grigi strettamente raccolti in una crocchia le davano un aspetto ordinato, mentre il viso del colore della cera rivelava che non usciva mai di casa. Non è che non le piacessero il sole o l’aria fresca, al contrario, ma era troppo grossa per camminare e, quando ci provava, dopo pochi passi le mancava il fiato. Oltretutto non aveva tempo perché doveva tener d’occhio la giovane nuora, nel caso la storia si ripetesse. Suo figlio assomigliava molto al padre e dipendeva dalla moglie che non si perdesse. Chi altri sennò! Dritto rovescio, dritto rovescio, dritto rovescio. Sapeva che si univano ogni notte, che alla giovane piacesse o no. Ne era sicura perché bastava origliare fuori della porta o guardare dal buco della chiave. Era gelosa della loro intimità, ma era essenziale mantenerlo soddisfatto e dargli da mangiare bene. Gli uomini erano così, bassi, come le bestie!
La zia corse di nuovo in cucina spingendo distrattamente la porta dietro di sé. Non si chiuse completamente, ma lei era troppo preoccupata per accorgersene. “Gemma... Gemma!” gridò. “Svegliati! Torna in qua. Non puoi fermarti adesso o il bambino muore. Devi spingere!” Le diede due schiaffi, uno per guancia, e Gemma aprì gli occhi.
“Sono tanto stanca...” sussurrò, gli occhi offuscati socchiusi per pochi secondi. Abbassò di nuovo le palpebre pesanti mentre girava la testa sul cuscino, lentamente.
“Non puoi fare così!” gridò la zia. “Devi spingere fuori il bambino!” Si passò le dita incerte tra i capelli. Col dorso della mano si asciugò il sudore sulla fronte e sul labbro superiore. “Se non spingi tu, allora spingo io!” dichiarò, disperata ma decisa.
Con le mani tremanti si arrotolò le maniche sopra i gomiti, sollevò la gonna sulle cosce e si mise a cavalcioni appena sopra la pancia gonfia. Si sistemò con le ginocchia ben piantate sul letto, i piedi accanto alla testa della cognata e, senza tante cerimonie, si sedette sul suo stomaco. Cominciò a spingere con tutto il corpo in giù... e in avanti, seguendo l’istinto che la guidava. “Dai Gemma, se vuoi che ti tolga il culo dalla faccia sarà meglio che cominci a spingere anche tu... tanto e forte!” ansimò. Premeva con le mani... in giù e in avanti, proprio sopra il pancione, mentre con le gambe muscolose le stringeva i fianchi. “Avanti, dai che ce la fai!” la incoraggiava, spaventata dalla sua stessa paura. “Spingi, spingi... dai, così. Non fermarti... dai dai... spingi! Facciamo uscire questo bimbo!”
Improvvisamente, come un’onda travolgente, Gemma percepì la corrente di determinazione e un brivido di amore le attraversò il corpo. Voleva che il suo bambino venisse al mondo sano e salvo; sapeva che poteva farlo. Cominciò a spingere cercando di seguire il ritmo della cognata che la cavalcava. Spinse... e spinse... e spinse...
La bimba sentì la pressione che ricominciava a sospingerla ritmicamente. Questa volta la forza era inarrestabile. La lunghissima e claustrofobica attesa nell’oscura galleria soffocante stava per finire e si trovò a precipitare in avanti, cercando disperatamente l’aria. Le mani della zia, calde del sangue della madre, erano pronte a prenderla e con forza la tirarono fuori del tutto.
Sentì un dolore al petto mentre traeva il primo respiro e poi tutto si rovesciò. Si trovò pericolosamente a testa in giù, presa per la caviglia, colpita ripetutamente. Finalmente cominciò a gridare e gridò... e gridò... e gridò, per paura di cadere nel vuoto senza fine, per l’angoscia del brutto viaggio nel canale buio, per il dolore di essere espulsa dal corpo di sua madre.
“È una bambina Gemma!” annunciò la zia enormemente sollevata, guardando la neonata. “Un’altra bambina.”
“Posso prenderla in braccio?” mormorò la madre tendendo le braccia per accoglierla. “Grazie!” disse, spostando lo sguardo pieno di gratitudine dai grandi occhi castani della cognata al piccolo viso pieno di lacrime. Le baciò le guance bagnate. “Ti voglio bene, anche se sei una bambina, mia piccola Maria,” le sussurrò con amore, gli occhi pieni di lacrime.
La nonna spalancò la porta: “Allora... l’hai fatto! Visto che potevi? Voi e l’ostetrica!” Sembrava che volesse sputare quelle parole, lanciando un’occhiata disinteressata al fagottino che urlava, sporco di sangue. “E hai fatto un’altra femmina, vedo... Come se due non bastassero già.”
“Non è colpa mia,” si difese Gemma debolmente, stringendo la bimba al petto.
“Abbiamo una nuova sorellina, mamma?” Le bambine si avvicinarono piene di curiosità. “Possiamo andare a dirlo al papà?”
“Tra poco arriverà a casa,” rispose la nonna con decisione. “Non vale la pena rovinargli la lezione di inglese. Se fosse stato un maschio...”
“Possiamo aspettarlo fuori allora?” supplicarono.
“Sì, fate così,” acconsentì la zia, “mentre noi sistemiamo la cucina. Ma mettetevi il cappotto. Fa molto freddo!”
Corsero fuori inosservate, senza cappotto o berretto e si misero a camminare in fretta verso la scuola serale.
“Ti piace la nuova bimba?” chiese la più giovane.
“No!”
“Perché no?”
“Perché doveva essere un maschio.”
“Ma anche noi siamo femmine!”
“Infatti, questo è il problema. Troppe femmine!”
La piccola cominciò a saltellare.
“Smettila!” comandò la più grande, dandole una sberla sulla testa.
“Perché non posso saltellare?” chiese la bambina, tenendosi a distanza di sicurezza. “Perché non posso?”
“Perché lo dico io!”
Avvistarono il padre in bicicletta che pedalava in fondo alla strada. Gli corsero incontro facendo a gara per arrivare per prima a dargli la notizia.
“Papà, la mamma ha avuto una bambina!” ansimò quella di sei anni, le treccine rigide nell’umidità della sera.
“Sta urlando proprio forte!” gridò quella di quattro, la coda di cavallo che dondolava.
“Una bambina?” disse il padre. “Un’altra femmina?”
Rallentò il pedalare mentre raggiungeva le due figlie.
“Mi fai montare sulla tua bici, papi?”
“Io voglio. Posso montare io con te, papà?”
“L’ho chiesto prima io!”
“Non m’importa. Io sono la più grande!”
Il padre non rispose. Saltellarono accanto alla bicicletta, ma lui andava troppo forte. Allora si misero a correre per stargli al passo, ma anche così rimasero indietro di un bel pezzo. Buttavano fuori il fiato caldo nella scura sera di novembre facendo a gara l’una con l’altra per vedere chi faceva le nuvolette più grandi.
Lo guardarono avvicinarsi alla casa col suo solito stile, sollevando la gamba destra e incrociandola dietro il piede sinistro sul pedale. Coprì gli ultimi pochi metri che mancavano scivolando elegantemente verso casa, come un pattinatore su una pista ghiacciata.
Paul e la partita di calcio
Anche quando era nato lui faceva freddo. La fine dell’inverno era vicina e nella foresta di Sherwood le prime timide gemme cominciavano già a sbocciare. Sua madre stava preparando l’impasto per una torta di more quando iniziarono le prime contrazioni.
“Credo che ci siamo amore,” disse al marito tenendo il pancione con le due mani. “Sta cominciando... ne sono quasi certa.”
“Ma è sabato Jane!” esclamò Bill con sgomento. “La partita di calcio comincia tra meno di... cosa... due ore?” Suo padre guardò l’orologio da polso con costernazione. “Non ho mai perso una partita! Sei sicura che abbia proprio cominciato? Non può aspettare fino a stasera?”
“Potrebbe essere un falso allarme, caro! Successe lo stesso con la nostra Catherine,” concesse la madre, massaggiandosi la parte bassa della pancia. “Perché non chiami l’ostetrica? Dopo puoi andare alla partita. Noi saremo tranquille e sono certa che tornerai in tempo.”
E così suo padre partì con la lucida automobile nera e tornò assieme all’ostetrica. Era una donna tedesca che viveva nella zona di Sherwood da molti anni; ne aveva perso il conto, ma aveva mantenuto un forte accento.
“Portami di sopra la valigia!” ordinò a Bill, “e vediamo a che punto siamo.”
Quando vide Jane tutta indaffarata a mettere in ordine la camera perse quel poco di pazienza che aveva.
“Non sei ancora pronta, donna! Perché mi avete chiamato così presssto?” Senza aspettare la risposta comandò: “Riporta giù la valigia! Mi dovrai riaccompagnare a casa e dovrò tornare più tardi.” Però per scrupolo, mentre Bill scendeva ubbidientemente le scale con la valigia, diede un’occhiata ‘all’uscita’ di Jane. Senza pronunciar parola corse a spalancare la finestra, si sporse di fuori e sbracciandosi gridò a Bill che era già nel cortile: “Torna su! Riportami la valigia. Non è troppo presssto. Sta venendo adesso!”
E così il bambino nacque in fretta e in un modo conveniente per tutti; talmente in fretta che il suo bel papà arrivò alla partita giusto in tempo per vederla cominciare.
Jane teneva il fagottino in braccio quando Catherine apparve sulla soglia. I grandi occhi verdi spalancati, pieni di muta preoccupazione, fissava sua mamma sul letto con un altro bambino.
“Vieni a vedere il tuo fratellino, Catherine.” Jane le porse la mano, ma lei non si muoveva, continuando a fissarli in silenzio.
“Vai a vedere il tuo nuovo fratello!” la incoraggiò l’ostetrica. Visto che la bambina non si decideva, la prese per mano e la portò dalla madre.
“Puoi toccarlo se vuoi,” disse Jane guardandola con amore.
Catherine non riusciva a staccare gli occhi dalle minute dita rosse del bambino. Le toccò con l’indice e sussultò dalla sorpresa quando il bimbo glielo strinse nella piccolissima mano. Guardò la madre, interrogandola con gli occhi sgranati. “Mi ha preso il dito e lo sta stringendo!” esclamò, stupefatta e divertita.
“Perché ti vuole già bene,” disse Jane accarezzandole i capelli. “Vieni a sederti sul letto.”
“Non è igggienico!” rimproverò l’ostetrica, che si chiamava Frida.
“Non preoccuparti Frida, staremo attente. Sei stata bravissima con il parto, grazie!”
Frida corrugò le sopracciglia, ma sapeva che il suo lavoro era finito e che era meglio tacere.
“Che nome gli diamo?” Jane domandò alla figliola, ma lei fissava il neonato, curiosa e confusa, e non rispondeva. “Lo chiamiamo Ernesto?”
La bambina scosse la testa per dire di no.
“Non ti piace il nome Ernesto?” Catherine scosse di nuovo la testa.
“E Paul ti piace? Lo chiamiamo Paul?” La bimba guardò il fratellino a lungo attentamente... e poi annuì.
“Posso dargli un bacio?” chiese finalmente.
“Ma certo! È tuo fratello e quando sarà grande ti proteggerà.”
Si appoggiò alla madre e baciò delicatamente il neonato su una guancia. Il bimbo aprì la piccola bocca sdentata e sbadigliò forte. Madre e figlia risero insieme, emozionate.
“È buffo!” disse sorridendo, sistemandosi più comodamente sul letto vicino alla mamma e offrendo il suo dito alla piccola mano del fratellino. Sorrise felice quando lui glielo prese e lo strinse forte.
Alcuni anni dopo: Maria
Giocava da sola con le bambole mentre le sorelle erano a scuola; la sua preferita era nera con i capelli ricci. Mentre sua madre faceva i lavori di casa lei le vestiva e le svestiva, cambiandole cento volte al giorno. Curiosa di sapere com’erano fatte, ne tirava le gambe e le braccia cercando di guardarci dentro. Era una tentazione irresistibile nonostante ormai sapesse che le bambole erano vuote. A volte l’elastico che le teneva unite si rompeva e le braccia o le gambe si staccavano, sconfitte. Finalmente poteva mettere il dito dentro quei buchi e accarezzare la plastica liscia.
“Vedrai come si arrabbiano le tue sorelle quando tornano da scuola e trovano le bambole rotte!” la rimproverava Gemma.
Con un pezzo di elastico nuovo riattaccava gli arti al corpo, ed era anche brava a farlo perché era difficilissimo, ma le braccia e le gambe non erano più belle unite come prima. E così tutte le bambole della casa avevano le membra un po’ lasche che dondolavano a penzoloni; non stavano più sedute bene e cadevano in avanti in segno di protesta. Le sorelle si arrabbiavano e quando la madre non era presente le davano qualche bella sberla per vendicarsi. Ma la curiosità vinceva sempre e il giorno dopo Maria tirava l’elastico di nuovo.
La nonna stava tutto il giorno in cucina seduta sulla sua sedia, lavorando a maglia in silenzio. Dritto rovescio, dritto rovescio, dritto rovescio. Da lì controllava tutto, ma soprattutto che la madre non uscisse, a parte quando andava a comprare il pane fresco. La sgridava se spostava la tenda della finestra per guardare fuori. Cosa c’era da guardare? Uomini?
“Cosa stai facendo nonna? È per me?” chiedeva Maria. Le piaceva sua nonna con la sua stazza grossa e confortante; si sedeva spesso sulla sedia vicina a guardarla lavorare a maglia.
“No, non è per te. Questo golf è per tua sorella più grande.”
“E quando l’hai finito ne fai uno per me?”
“Devi aspettare. Prima devo farne uno per l’altra tua sorella.”
“Quanto ci metti?”
“Due settimane, tre se non sto bene. Devi aspettare.”
“Me lo fai rosa?”
“Vedremo!”
E lei aspettava. Le ricordavano sempre che era la terza femmina per cui sapeva di non essere importante, anzi... era l’ultima ruota del carro! Le tre settimane sarebbero passate e la nonna avrebbe fatto un golf per lei. Maria aveva fiducia e aspettava.
La madre faceva tutti i loro vestiti. Stendeva bene la stoffa sulla tavola della cucina, faceva i segni con il gesso bianco da sarto, un gesso liscio che non sporcava le mani, tagliava la stoffa con delle forbici grandi e poi univa le parti con gli spilli.
“Mi aiuti Maria?” chiedeva alla bambina seduta dall’altra parte della tavola. “Se mi infili gli aghi lavoro molto più in fretta.”
Lei era bravissima a infilare gli aghi, più svelta di quanto Gemma fosse ad imbastire. Si leccava il dito, faceva il nodo e poi lisciava il filo sulla formica gialla della tavola.
Quando Maria aveva quattro anni Gemma rimase incinta di nuovo. In primavera aveva già il pancione e le serate erano tiepide. Dopo cena tutta la famiglia si sedeva nel giardino che dava sulla strada a bere birra, perché faceva venire il latte. Era vero che loro non avrebbero allattato, ma la birra la bevevano tutti, bambini compresi. Maria ne odiava il gusto amaro, ma siccome per una volta tanto la trattavano alla pari, la beveva anche lei. E poi ridevano e saltavano sui letti; soprattutto la sera in cui Gemma entrò in travaglio. Come se sapesse che questa volta sarebbe arrivato il maschio, il padre l’aveva portata in clinica. Nel giro di dieci minuti il fratellino era già nato, anzi, per poco non finiva giù per il water quando Gemma andò a fare pipì. Per fortuna riuscì a tener duro e ad arrivare fino al primo letto. Sarebbe stato un inizio poco dignitoso per l’erede del nome Dal Fiore! In ogni caso, in cinque minuti era venuto al mondo e la mattina dopo erano già di ritorno a casa.
Un giorno venne un’ambulanza e portò via la nonna. Maria stava andando a trovarla in ospedale con sua zia quando incrociarono il padre che tornava in bicicletta. Si fermò, un piede per terra e uno sul pedale. Guardando sua sorella scosse il capo. “Il cuore... ” disse.
Lei e la zia tornarono a casa. Le mancava la presenza della nonna che lavorava a maglia seduta su quella sedia, ma di lei non parlarono quasi più.
Un mese dopo il padre fece andare tutti giù in cortile e con orgoglio mostrò una grande macchina rossa con il tetto nero, una FIAT di seconda mano che era come nuova. Aveva preso la patente di nascosto, ma spesso si chiedevano se davvero gliel’avevano data perché a loro non sembrava che guidasse molto bene. Era nervoso e sorpassava le altre automobili per dimostrare la sua superiorità a tutti gli altri conducenti. Di fianco a lui, la madre era sempre piena di angoscia. Si metteva la mano sulla bocca e diceva: “Va’ piano, Piero. Non sorpassare, sta arrivando un camion!” oppure: “La curva è stretta. Perché non rallenti un poco?”
Ma il padre si innervosiva ancora di più e quando si degnava di risponderle diceva: “Se non ti va bene Gemma, puoi scendere e andare a piedi!”
Seduta dietro con le sorelle e il fratello, le veniva sempre da ridere quando sentiva quella frase. Anzi, a volte la dicevano i figli stessi ridendo a crepapelle: “Se non ti va bene Gemma, scendi e vai a piedi!”
La madre teneva gli occhi chiusi dal terrore. Una volta giunti a destinazione il padre osservava: “Hai fatto un bel pisolo, eh Gemma! Siamo già arrivati e non te ne sei neanche accorta!”
Alcuni anni dopo: Paul
Più cresceva e più somigliava a sua sorella, con i riccioli biondi e i grandi occhi verdi. Giocavano insieme nel grande giardino dove sua madre coltivava fiori bellissimi di tutte le misure, forme e colori. C’erano fiori in primavera, in estate e perfino in autunno. Gli piaceva cercare ‘creature’ nella terra, ma Catherine scappava gridando quando tentava di mostrarle i vermi che aveva trovato. Per fortuna che spesso venivano i cugini, due femmine e un maschio dell’età di Paul. Scavavano insieme per trovare vermi e insetti di ogni tipo.
Jane coltivava anche verdure in giardino. Cuoceva il pane e i dolci al forno sprigionando un profumo meraviglioso e faceva anche il vino. In autunno mandava i bambini a raccogliere more, consegnando loro un grande secchio di ferro. Tornavano a casa solo quando era completamente pieno e, da quanto pesante era, dovevano portarlo in due. Jane ne era sempre contentissima; diceva loro che erano stati bravi e dava a ciascuno una fetta di dolce e un bicchiere di latte, già pronti sulla tavola col piattino e il tovagliolo. Poi con quelle more faceva i dolci e il vino.
Suo padre era quasi sempre a letto nella camera di sopra che dava sul giardino. Paul gli portava il giornale e il viso di Bill si illuminava in un gran sorriso. Prendeva il giornale con le sue mani magre, eleganti. Nonostante il pallore e la malattia era sempre molto bello, aveva gli occhi buoni.
“Siediti qui con me che ti leggo le ultime notizie,” diceva facendogli posto vicino a lui. “A meno che tu non preferisca che ti racconti una storia!”
“Mi racconti quella del piccolo Buddha?” chiedeva il piccolo, speranzoso.
“Di nuovo? Ma te l’ho già raccontata mille volte. Non sei stanco di sentirla?”
Ma Paul non ne era mai stanco e inoltre suo padre aggiungeva sempre dei particolari nuovi. Si sedeva a gambe incrociate sul letto vicino a Bill, pronto ad ascoltarlo.
“Ti racconto di quando si trovò faccia a faccia con una tigre. Ti piace quella, no?”
Lui adorava quella storia e annuiva con entusiasmo.
Ancora una volta Bill cominciò: “Un giorno Siddharta, così si chiamava il Buddha, andò a caccia della tigre con suo padre, il re Suddhoddana. Era la prima volta perché, essendo una caccia molto pericolosa, i bambini non potevano parteciparvi. Ma siccome Siddharta aveva appena compiuto undici anni, dopo l'enorme festa in suo onore, con tavole imbandite di dolci e frutta, suo padre decise che era ormai abbastanza grande per portarlo con sé insieme agli altri uomini.”
Paul ascoltava attento e chiese: “Non aveva paura?”
“Chi, Siddharta?” chiese Bill guardando il figliolo. Il bambino assentì. “Oh no! Come tanta gente buona aveva molto coraggio! Andiamo avanti?”
Paul annuì forte, sorridendo felice.
“Allora, erano in groppa all’elefante del re, con Siddharta accomodato sul collo grosso e morbido e il re seduto dietro di lui. Senza rendersene conto si trovarono separati dal resto del gruppo quando, all’improvviso, l’elefante si fermò. Aveva sentito un rumore preoccupante proveniente dal bosco di bambù e d’istinto capì che c’era un pericolo. Si abbassò sulle zampe anteriori, preparandosi ad attaccare con le zanne qualsiasi animale lo avesse minacciato!”
Paul sollevò il viso verso suo padre guardandolo ad occhi spalancati, ricordandosi quello che stava per succedere. Bill gli fece l’occhiolino, lo circondò col braccio e continuò: “Siccome Siddharta e suo padre riuscivano a tenersi a malapena in equilibrio sul collo dell’elefante, quando questo fece un movimento brusco si trovarono scaraventati al suolo. Improvvisamente, un’enorme tigre apparve dal bosco di bambù. Il re mise la mano sulla spalla del figlio, ma Siddharta sentì che stava tremando. Senza pensarci due volte, si mise davanti al padre per schermarlo.”
La storia non perdeva mai il suo fascino e Paul tratteneva il fiato. Bill gli diede un colpetto sul ginocchio e continuò: “Soltanto il re Suddhoddana aveva la spada perché al ragazzo, essendo troppo giovane, non era permesso portare un’arma. Nonostante ciò Siddharta non aveva timore. Era faccia a faccia con la tigre e questa aveva il pelo folto e lucido... Era stupenda! La guardò negli occhi: erano gialli, grandi... e pieni di paura. La tigre lo fissava, immobile. Per un lungo istante si studiarono intensamente. ‘Non avere paura, non voglio farti del male,’ voleva dirle, ma siccome le parole non avrebbero funzionato, glielo disse con gli occhi e con tutto se stesso. Era sicuro che lei lo capiva. Lentamente la preoccupazione svanì e si trasformò in curiosità e negli occhi della tigre Siddharta vide una specie di interesse, forse addirittura complicità.”
Paul era tutto teso ad ascoltare la storia e suo padre continuò lentamente: “Allora, volendo rassicurarla, strizzò gli occhi per comunicarle che la rispettava e la capiva. In risposta, la tigre abbassò una palpebra, appena appena. Erano diventati amici e riuscivano a comunicare. Nella giungla c’era un silenzio di tomba, come se tutti gli animali stessero trattenendo il respiro. Siddharta fece un passo verso la tigre; lei non si mosse. Lentamente, le porse la mano a palma in su, per dirle che poteva rilassarsi. La tigre abbassò leggermente la testa, con un grugnito si girò e si allontanò ancheggiando, scomparendo di nuovo dentro la foresta di bambù.”
Paul tirò un gran sospiro di sollievo. Suo padre concluse la storia: “Il re era molto orgoglioso di suo figlio. ‘Hai battuto la tigre,’ gli disse. Ma Siddharta le aveva solo parlato col pensiero e aveva sentito la sua paura. Da parte sua, la tigre aveva percepito la sua bontà, questa cosa tanto speciale in quel ragazzo, e aveva avuto fiducia in lui.”
Paul sorrise con un’emozione dentro che lo faceva tremare, come se avesse sentito la storia per la prima volta: “Siddharta era più coraggioso e più forte del re, vero papà?”
“Sì, molto. Era forte dentro di sé. Aveva molta compassione e questa era la sua forza.”
Paul si rannicchiò il più vicino possibile a suo padre che se lo strinse forte al fianco. Alzò il viso a guardarlo e Bill gli baciò i capelli biondi. Rimasero così, senza parlare, nel letto caldo... per un bel po’.
Quando suo padre andò in ospedale Jane andava a trovarlo ogni giorno, mentre loro passavano il pomeriggio a casa dei cugini. Un giorno Jane tornò a casa della zia con gli occhi rossi e gonfi. Continuava a soffiarsi il naso dentro un fazzoletto da uomo, di quelli grandi e bianchi con il bordino blu che aveva Bill. Quando arrivarono a casa preparò tre tazze di latte caldo e si sedettero intorno alla tavola della cucina a sorseggiarlo in silenzio.
“Il papà non c’è più,” disse ai bambini. “Ma io sono qui e non vi lascerò mai, per cui non dovete avere paura.”
“Dove è andato il papà?” chiese Catherine, sentendo il panico che l’assaliva e le stringeva il cuore.
“È andato dove non si soffre più,” rispose Jane guardando i figli dall’uno all’altro. “Ma vi vorrà sempre bene. Non dovrete mai dimenticarlo!”
“È andato in Nirvana?” chiese Paul.
La madre lo guardò sorpresa e sorrise dolcemente. “Non è un posto tesoro, è uno stato di pace e tranquillità, ma... sì, adesso il babbo è in Nirvana,” confermò accarezzandogli la testa.
“Il papà ha detto che è uno stato!” replicò lui fiducioso.
“Sì, caro!” rispose la madre con un sorriso triste.
Paul sapeva molte cose sul Nirvana. Bill gli aveva detto che era uno stato in cui non si soffriva, anzi si stava proprio bene! Come diceva anche la mamma, c’era pace e tranquillità e nessun timore. Probabilmente era uno stato dove le tigri non avevano paura della gente e i bambini potevano giocarci insieme, magari anche cavalcarle. E forse, in Nirvana, i bambini facevano dei bei pisolini al calduccio in letti comodi, con il loro papà. E da lì i papà non dovevano andarsene mai.
Cominciarono ad andare dai cugini ogni pomeriggio mentre Jane era al lavoro. La zia ebbe un’altra bambina e lasciava che Paul la tenesse in braccio. Aveva dei grandi occhi azzurri e gli sorrideva e questo lo rendeva felice. Ogni sera la madre veniva a prenderli e tornavano a casa. Aveva comprato dei pulcini che poco a poco diventarono galline. Ogni mattina Paul andava in cerca delle uova; a volte le trovava che erano ancora calde e, anche se erano un po’ sporche, le portava a casa avvolte nel maglione. Jane aveva comprato anche dei conigli che tenevano in una cassetta con la retina davanti. I bambini strappavano manciate di erba e le porgevano agli animaletti attraverso la retina. I conigli erano simpaticissimi, prendevano l’erba con le zampine anteriori e la masticavano in fretta con grande entusiasmo, facendoli ridere di soddisfazione. Dopo un po’, siccome nessuno poteva o voleva ucciderli per mangiarli, li lasciarono liberi nel giardino a saltellare e a moltiplicarsi felicemente. Ma un giorno mangiarono tutti i fiori e Jane li dette via.
Per andare al capitolo 1 clicca qui: Capitolo 1
Disponibile presso Amazon in tutto il mondo in versione cartacea o per Kindle. Se sei in Italia, ordina la tua copia direttamente da Amazon.it: http://www.amazon.it/Made-Nirvana-Emanuela-Cooper/dp/1515382516/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1450548022&sr=1-1&keywords=made+in+nirvana